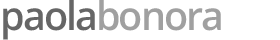Io, il manichino

Ci sono figure che ci accompagnano da sempre, ma che raramente hanno avuto diritto di parola. Corpi docili e senza identità, disposti in vetrina per offrire la propria immobilità a servizio dell’immaginazione altrui. I manichini sono creature artificiali ma così simili all’umano, di cui sono specchio scomodo: rassicuranti nelle forme e al contempo inquietanti perché somiglianti a noi, sebbene spesso privi di testa e volto, cioè di quelle parti del corpo con cui ci relazioniamo più spesso. Poteva forse non esserci una fobia per questo tipo di cose? Certo che no: esiste e si chiama automatonofobia, cioè una paura irrazionale verso tutto ciò che riproduce in modo artificiale una figura umana.
Ma l’arte di Paola è invece da sempre popolata di presenze vive, seppure discrete e misteriose: dagli uomini volanti con eleganti cappotti aperti (dopo oltre 25 anni di amicizia ho scoperto solo di recente che si chiamano Max), al tourbillon di gatti, cani, cardellini, piante di ogni tipo, per non parlare di tutti quei vestiti e cappelli eleganti che più volte si sono rincorsi nelle sue opere. Seppure oggetti inanimati sono testimoni di una grande energia e vitalità, capaci di raccontare storie suggestive. È successo alcune volte provando ad unire il filo tra parole e acquerelli, come nel racconto Interno con Cappello, un piccolo noir onirico che scrissi inseguendo alcune sue opere tra loro affini, ormai quattordici anni fa. Ancora di più è successo nel libro di racconti Armadi, che Paola ha scritto e pubblicato nel lontano 1996. Storie, persone, poesie, una narrazione per immagini dove i sentimenti emergevano chiaramente in modo sottile e intelligente, dove aprendo le porte di un guardaroba si scoprivano mondi, vite quotidiane e segreti inconfessabili.
Così oggi sembra quasi di chiudere un cerchio ammirando le forme inerti dei manichini che hanno indossato quei vestiti e si incontrano muti in questa galleria, “piccola, ma adatta a me”. La musica è finita, gli amici se ne vanno, nei cassetti restano i ricordi e tanti di quegli abiti che hanno fatto a loro modo la nostra storia non ci sono più. I busti bianchi non dialogano ma assistono immobili, non parlano ma raccontano moltissimo di ciò che è stato, delle proiezioni di vite passate, di giornate memorabili e di periodi bui. Privi di tessuti e drappi che li hanno resi importanti e appariscenti, non restano che forme abbozzate di qualcosa che è già stato, ma che potrebbe ancora essere altro, domani.
E l’acquerello di Paola, rarefatto ed essenziale nelle sue sfumature leggere, privo di ogni connotazione temporale e spaziale, diventa il linguaggio ideale per restituire al manichino la sua voce silenziosa. Le opere in mostra lo ritraggono così: fragile e solido al tempo stesso, legato da nastri che sembrano abbracci o catene, avvolto da drappi che non diventano mai abiti, circondato da altri suoi simili come in un ballo senza musica. L’acqua scorre e macchia la carta con una leggerezza che contrasta con la rigidità di questi oggetti antropomorfi: il manichino, solitamente glaciale, si rivela invece oggetto poroso, attraversato dai nostri sguardi, dalle nostre attese, dalle nostre proiezioni.
La tradizione artistica ne ha fatto una presenza costante, dal metafisico di De Chirico ai paesaggi onirici del Novecento, fino alle ricerche contemporanee che lo interpretano come icona di consumismo e serialità. Qui sembra invece protagonista di una narrazione più intima: non il simulacro che abita le vetrine, ma il compagno silenzioso che ci osserva dal fondo di un sogno. È un contenitore di desideri? Una parodia dell’umano? O un avvertimento sulla nostra stessa condizione di esseri sospesi, in bilico tra libertà e costrizione?
Guardando questa collezione di senza testa (ma con un corpo perfetto e invidiabile) possiamo sorridere: perché i manichini in fondo, siamo un po’ anche noi. Che ugualmente ci mettiamo in mostra, recitiamo ruoli, restiamo in attesa di un vestito che ci definisca. E proprio come loro, spesso siamo presenze mute in un mondo che ci osserva e ci giudica più di quanto ci ascolti davvero.
Eugenio Ciccone